Sclerosi multipla: scoperto un bersaglio immunitario per terapie più sicure e mirate

Illustrazione di un fiocco giallo e rosso (Canva FOTO) - biomedicalcue.it
In futuro saranno possibili nuove terapie, e questo grazie alla scoperta fatta da uno studio condotto da ricercatori dell’Università di Padova.
La sclerosi multipla (SM) è una malattia autoimmune che colpisce milioni di persone nel mondo e che, nella sua fase iniziale, vede le cellule immunitarie attraversare i vasi sanguigni e raggiungere il sistema nervoso centrale, dove innescano processi di infiammazione e degenerazione delle fibre nervose.
Negli ultimi anni è diventato chiaro che una particolare categoria di linfociti T, chiamati effector memory T cells (TEM), gioca un ruolo chiave nell’attacco alla mielina, il rivestimento protettivo dei neuroni. Queste cellule, una volta attivate in modo ripetuto, riescono a superare la barriera emato-encefalica e ad avviare un circolo vizioso di danni e infiammazione che porta ai sintomi tipici della malattia.
Le terapie attualmente in uso cercano di bloccare o modulare l’attività di queste cellule, ma spesso lo fanno in modo poco selettivo, finendo per indebolire l’intero sistema immunitario. Uno dei bersagli molecolari più interessanti individuati negli ultimi anni è il canale del potassio Kv1.3, particolarmente espresso nei linfociti T della memoria effettori. In molti studi questo canale si è rivelato essenziale per la proliferazione e l’attivazione delle cellule coinvolte nella risposta autoimmune.
Da qui nasce l’idea di intervenire non sul canale Kv1.3 di superficie, ma su quello presente all’interno dei mitocondri, una sorta di “seconda versione” del canale, capace di modulare il metabolismo cellulare e la produzione di radicali liberi. Il composto PAPTP, sviluppato per attraversare le membrane e raggiungere i mitocondri, sembra colpire in modo selettivo proprio le cellule T cronicamente attivate, inducendo stress ossidativo e apoptosi.
Inquadramento del problema
Le forme più comuni di sclerosi multipla, come quella recidivante-remittente, mostrano una forte componente immunitaria legata alla presenza di linfociti autoreattivi contro proteine della mielina. Una parte consistente di questi linfociti presenta un fenotipo effector memory, caratterizzato da alta capacità di proliferazione e reattività, oltre che da una notevole abilità nel superare le barriere protettive dell’organismo.
Gli esperimenti condotti negli ultimi anni hanno dimostrato che, dopo l’attivazione ripetuta, queste cellule esprimono livelli elevati del canale Kv1.3, sia sulla superficie cellulare sia nei mitocondri. Ed è proprio questa caratteristica metabolica, legata anche a una maggiore produzione di specie reattive dell’ossigeno, a renderle vulnerabili a molecole in grado di interferire con il canale mitocondriale.
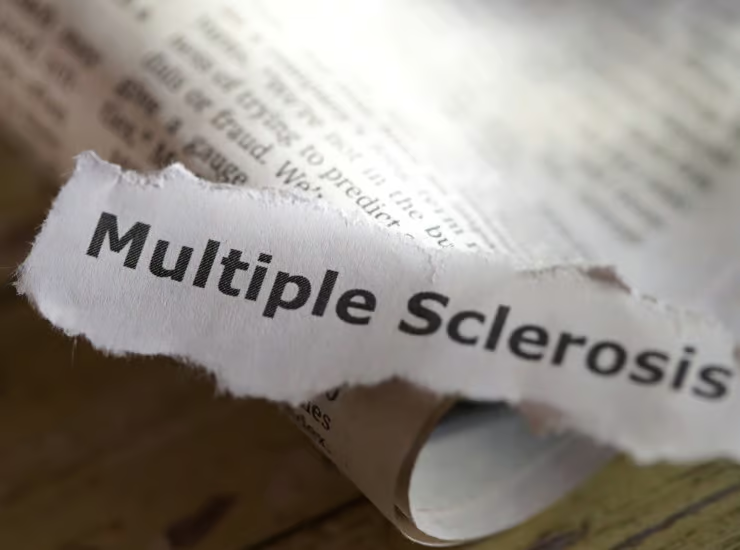
I risultati sperimentali e loro implicazioni
Lo studio dimostra che l’inibizione selettiva del canale mitoKv1.3 tramite PAPTP porta alla morte delle cellule TEM autoreattive, senza influenzare le altre popolazioni linfocitarie. In campioni di sangue prelevati da pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente, il trattamento con concentrazioni micromolari di PAPTP ha ridotto in modo significativo la quota di linfociti patologici, lasciando invariati i linfociti naïve e le cellule T della memoria centrale. Nei modelli murini di encefalomielite autoimmune sperimentale (EAE), l’iniezione del composto ha impedito completamente lo sviluppo della malattia quando somministrato prima dell’insorgenza dei sintomi, e ne ha rallentato la progressione quando usato in fase già conclamata.
L’effetto terapeutico è legato a un meccanismo di apoptosi indotto dall’aumento dello stress ossidativo nei mitocondri delle cellule ad alta espressione di Kv1.3. Questo porta al rilascio di citocromo c e all’attivazione della cascata di morte cellulare programmata. Anche nei casi in cui non tutte le cellule TEM venivano eliminate, la loro riduzione sotto una certa soglia era sufficiente a bloccare l’evoluzione della malattia, riducendo demielinizzazione, degenerazione neuronale e deficit motori. Il composto si è inoltre dimostrato stabile nel sangue, selettivo e privo di effetti tossici sistemici, distinguendosi nettamente dai farmaci immunosoppressori attualmente in uso.
